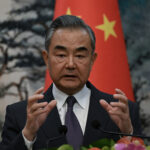Crisi a Gaza: dall’attacco del 7 ottobre la Cina ha cercato di proporsi come un interlocutore super partes tra Palestina e Israele, vantando buoni rapporti un po’ in tutto il Medio Oriente. Oltre il linguaggio felpato della diplomazia, occorre però notare l’esistenza di impercettibili chiaroscuri. Il dibattito online e sui media statali si rivela molto utile per cogliere le sfumature della postura cinese. La nostra analisi per Gariwo Onlus.
“Il cessate il fuoco e la fine dei combattimenti non possono più essere rinviati”. Lo ha ribadito pochi giorni fa l’ambasciatore cinese presso le Nazioni Unite, Zhang Jun. Per Pechino quella a Gaza è una questione umanitaria. Le “considerazioni geopolitiche e i doppi standard” dell’occidente rischiano solo di prolungare il conflitto.
Dall’attacco del 7 ottobre la Cina ha cercato di proporsi come un interlocutore super partes tra Palestina e Israele, vantando buoni rapporti un po’ in tutto il Medio Oriente. La conclamata “neutralità” cinese tuttavia presenta gli stessi limiti già evidenziata nella guerra in Ucraina. Senza mai nominare Hamas (come innominata resta l’invasione russa) Pechino si è detto “profondamente rattristato dalle vittime civili causate dal conflitto tra Palestina e Israele”. In compenso – senza giri di parole – ha accusato Tel Aviv di aver risposto all’attacco di Hamas “oltre l’ambito della legittima difesa.” D’altronde, secondo le autorità cinesi, l’origine stessa della crisi nella Striscia risiede nell’ “’ingiustizia storica subita dal popolo palestinese” e l’unico modo per riportare la pace consiste nella “soluzione dei due Stati” con l’istituzione di uno Stato palestinese con Gerusalemme Est come capitale.
Oltre il linguaggio felpato della diplomazia, occorre però notare l’esistenza di impercettibili chiaroscuri. Il dibattito online e sui media statali si rivela molto utile per cogliere le sfumature della postura cinese: quello che Pechino pensa ma non può dire spesso trova spazio sugli organi di informazione ufficiali sotto forma di editoriali e interviste. Ugualmente, osservare l’umore del web può aiutare a ricostruire a ritroso le direttive della propaganda governativa. Considerato il controllo stringente della censura, la narrazione dominante sui social network cinesi – se sopravvive nel tempo – solitamente si afferma proprio grazie al placet delle autorità.
Le tre narrazioni
Con queste premesse, risulta comprensibile l’indignazione suscitata all’estero dalla discutibile professionalità con cui l’emittente statale CCTV ha raccontato (e sta ancora raccontato) la crisi a Gaza: nessuna menzione dei 240 ostaggi catturati da Hamas e copertura decontestualizzata dei bombardamenti israeliani. Di riflesso le discussioni in rete sembrano aver inevitabilmente risentito della linea concertata dall’alto. Che si sia parlato degli scontri – e anche parecchio – è già un elemento da non sottovalutare: vuol dire che Pechino vuole (o quantomeno accetta) che se ne parli. Tra il 7 e il 19 ottobre, su Weibo l’hashtag #Conflitto israelo-palestinese (#巴以冲突#) ha ricevuto oltre 2 miliardi di visualizzazioni, mentre l’esplosione dell’ospedale di Gaza (#加沙地带一医院遭袭数百人死亡#) ha ricevuto oltre 320 milioni di visualizzazioni in un solo giorno. All’analisi quantitativa occorre affiancare un’analisi quantitativa. Dato che della crisi se ne parla, come se ne sta parlando?
La Cina filopalestinese da Mao a Xi Jinping
Secondo il sito What’s On Weibo, sono almeno tre le narrazioni emerse dall’inizio dei combattimenti. La prima amplifica i toni “filopalestinesi” dei media ufficiali indugiando sulla sofferenza dei civili nella Striscia. “Sostenere la Palestina significa sostenere la giustizia e i deboli,” osserva il blogger Creamy Banana, che su Weibo ha 140.000 follower. Si tratta di una visione che attinge alla retorica anti-imperialista ereditata dalla Cina di Mao e cavalcata dall’amministrazione Xi Jinping per respingere le lectio magistralis dell’occidente in materia di “neocolonialismo”.
La postura di Pechino nel conflitto israelo-palestinese risale agli anni ’60, quando la Cina arma e addestra militarmente i guerriglieri palestinesi. Sono gli anni dei movimenti di indipendenza dall’occupazione occidentale. Poi la metamorfosi del Pcc da partito rivoluzionario a partito di governo modifica le priorità in cima all’agenda estera cinese. Negli anni ‘90 la Cina stabilisce rapporti diplomatici con Israele, di cui oggi è il secondo partner commerciale. Ma sul web c’è chi, ancora oggi, nei “bambini di Gaza, scossi e tremanti sotto i bombardamenti israeliani” ci rivede gli orrori della Guerra di Resistenza contro il Giappone. Altri ancora, tifando Palestina, sentono di dover reciprocare il supporto fornito dai paesi arabi negli anni ‘60-’70, quando la Repubblica popolare era isolata a livello internazionale.
Ma non sono mancati commenti più radicali, persino di aperta condanna nei confronti non solo di Tel Aviv, ma anche più in generale del popolo ebraico. Espressioni di approvazione nei confronti dello sterminio nazista hanno costretto le ambasciate tedesca e israeliana in Cina a disattivare la funzione commenti sui loro account social. “Auschwitz sente la vostra mancanza”, ha scritto un utente sotto un post pubblicato dalla sede diplomatica di Tel Aviv. Su Douban, piattaforma di discussione dedicata all’entertainment, Schindler’s List, il cult del 1993 diretto da Steven Spielberg sulla shoah, è stato travolto da voti negativi, mentre offline si sono verificate vere e proprie aggressioni contro cittadini israeliani. Il vulnus, secondo molti, consiste nel presunto controllo esercitato dagli ebrei sull’economia e la politica americana. Semplice disinformazione o c’è dell’altro?
Il fattore americano dietro all’ “antisemitismo” cinese
Come ci spiega un esperto di relazioni internazionali residente a Shanghai, “i cinesi non hanno anticorpi contro questo genere di rumors”. Un aspetto che ricorda il sentimento islamofobico e il razzismo contro gli africani divampati negli ultimi anni sui social cinesi. Ma occorre anche notare come la percezione dell’opinione pubblica sia in buona parte influenzata dalla vulgata degli organi di informazione cinesi.
A ottobre, per esempio, la CCTV ha rilanciato la clip di un programma del 2020 intitolato “Uncovering the Israel Element of U.S. General Elections”, in cui si sostiene che “gli ebrei, pur rappresentando solo il 3% della popolazione degli Stati Uniti, monopolizzano il 70% della sua ricchezza”. L’hashtag correlato alla trasmissione ha ottenuto quasi 100 milioni di visualizzazioni su Weibo ed è stato tra i temi del giorno più discussi. Sullo stesso spartito Wu Sike: l’ex inviato speciale della Cina in Medio Oriente recentemente ha associato la posizione pro-Israele di Joe Biden alle presidenziali del 2024 e alla necessità di ottenere i voti dell’influente elettorato ebraico. La crisi a Gaza, e il conseguente deragliamento dei colloqui tra Israele e l’Arabia Saudita (fortemente voluti da Washington), rappresentano un “duro colpo” per una riconferma di Biden alla Casa Bianca, suggerisce il diplomatico.
Si è spinto oltre Wang Jin, docente di Middle East Studies presso la Northwest University, secondo il quale l’attuale escalation nella Striscia è il prodotto dell’inettitudine americana. L’ ‘Accordo del secolo’ e gli accordi arabo-israeliani di Abramo promossi da Trump – accusa l’accademico – “hanno eroso radicalmente le basi del dialogo tra Palestina e Israele trasformando la questione storica in un problema di sviluppo economico.“
Ecco che il fattore americano si rivela fondamentale per comprendere l’apparente “antisemitismo” cinese. “Dato il pieno sostegno dell’America a Israele, la Cina doveva necessariamente posizionarsi dalla parte opposta”, spiega a Gariwo Carice Witte, fondatrice ed Executive Director del think tank israeliano SIGNAL Group. Questo spiega in parte l’improvvisa ostilità dei cinesi nei confronti di Israele. Se non improvvisa, perlomeno “astorica” considerato che tra il 1933 e il 1941 la città di Shanghai aprì le porte a oltre 18.000 ebrei in fuga dalle persecuzioni naziste. Senza contare che, se la disinformazione ha contribuito ad alimentare la recente ondata antisemita, allo stesso tempo sussistono altrettanti stereotipi positivi: oltre la Muraglia gli ebrei sono tradizionalmente considerati scaltri e abili investitori. Un giudizio “generalmente positivo” documentato persino in un sondaggio condotto nel 2016 da China Radio International.
Le ambizioni globali di Pechino
Uno: solidarietà filopalestinese di storica memoria. Due: “antisemitismo” in chiave antiamericana. Il terzo trend rilevato da What’s on Weibo è invece collegato alle ambizioni globali di Pechino. Mentre la diplomazia mandarina in Medio Oriente ragiona soprattutto in termini economici, non si possono ignorare i risvolti geopolitici. Pechino sa che simpatizzare per il popolo palestinese può facilitare affari con gli altri membri della Lega araba (la maggior parte dei quali non riconosce Israele): soprattutto Iran e Arabia Saudita, due dei principali fornitori di petrolio diventati centrali anche nello sviluppo della nuova via della seta. Eppure è indubbio che il fattore politico-ideologico concorre a plasmare la posizione cinese nella Striscia. Dopo il fruttuoso negoziato tra Teheran e Riad della scorsa primavera, la Cina ora punta a presentarsi come una potenza pacifica in contrapposizione al militarismo degli Stati Uniti. Un’operazione che strizza l’occhio al cosiddetto Sud Globale, dove l’immagine di Washington risulta macchiata dal decennale coinvolgimento nei vari conflitti mediorientali. A questo fine Pechino ha auspicato “la convocazione di una conferenza internazionale di pace più autorevole, influente e con una base ampia, sotto gli auspici delle Nazioni Unite”. Come avvenuto in Ucraina, anche a Gaza, il gigante asiatico si erge a difensore dell’ordine internazionale. Un ordine da cui la Cina sa di poter ancora beneficiare.
Parteggiando per la Palestina, Pechino può infatti raccogliere ulteriori consensi in merito alla scivolosa questione dello Xinjiang, la regione autonoma cinese dove si sospettano gravi violazioni dei diritti umani contro le minoranze etniche di religione islamica. I paesi arabi si sono già dimostrati piuttosto solidali con Pechino, appoggiando le varie risoluzioni cinesi presentate in risposta alle accuse dell’Occidente in sede Onu. Finora i numeri dei votanti amici hanno quasi sempre premiato la Repubblica popolare.
Con la crisi a Gaza, assume ancora maggior peso il recente endorsement di Abu Mazen: a giugno, in visita oltre la Muraglia, il presidente palestinese aveva condannato le “interferenze negli affari interni della Cina” dichiarando che le politiche di Pechino nello Xinjiang “non hanno nulla a che fare con i diritti umani e mirano ad eliminare l’estremismo e a contrastare il terrorismo e il separatismo”. Un favore che le autorità cinesi hanno ricambiato evitando di definire Hamas “un’associazione terroristica”, laddove la controffensiva israeliana nella Striscia sui social media è stata equiparata a un “genocidio”.
La Cina cambia tono
Va detto tuttavia che negli ultimi tempi i toni del dibattito in Cina sono cambiati. Sono sempre di più i netizen a esprimere comprensione nei confronti della reazione israeliana all’attacco del 7 ottobre. “Mi sembra ci siano meno commenti antisemiti online”, conferma a Gariwo Ma Wenhao, giornalista di VOA e attento osservatore dell’internet cinese. “E’ difficile dire se sia la conseguenza di un ripensamento della censura”, chiarisce il reporter. Il clima in rete – spiega Ma – si è disteso dopo che alcuni blogger nazionalisti hanno iniziato a difendere le loro opinioni antisemite in risposta ad alcuni articoli comparsi su New York Times e Wall Street Journal. “Ora [questi utenti] affermano di essere in realtà antimperialisti invece che antisemiti. In ogni caso, non mi sorprenderei se la censura cinese avesse deciso di reprimere l’antisemitismo essendosi resa conto della reazione critica nel resto del mondo,” azzarda il giornalista.
Ma non è l’unico a interpretare il cambio di passo in un’ottica strategica. “L’esplosione dell’antisemitismo presto si è rivelata destabilizzante”, racconta Witte, appena rientrata da una visita in Cina per presenziare al Forum Xiangshan sulla sicurezza. E aggiunge: “Alla fine di ottobre, istituti e università cinesi hanno ricevuto una direttiva per rinviare seminari e discussioni su Israele e Medio Oriente per evitare conflitti. Gli incontri universitari di SIGNAL in tutto il paese sono stati cancellati tranne quelli previsti a Pechino”. “Forse riconoscendo che il sentimento antisemita stava diventando problematico, il governo cinese ha deciso di dettare un nuovo tono”, ipotizza l’esperta, notando come “l’aggiustamento della narrativa online ha coinciso con la conferma della visita di Xi Jinping a San Francisco per l’APEC”. Considerato “l’approccio più modulato di Pechino nei confronti di Washington, che prevede l’invio di alti funzionari cinesi negli Stati Uniti”, Witte è piuttosto convinta: “Frenare i messaggi al vetriolo contro Israele doveva forse servire a creare un’atmosfera più favorevole alla ripresa del dialogo”.
Di Alessandra Colarizi

Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.