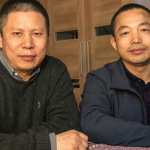Quella della “punizione collettiva” non è un’usanza introdotta in tempi recenti, bensì un retaggio del periodo pre-imperiale. Un rapporto di Chinese Human Rights Defenders (CHRD) dimostra come il governo cinese continui a farne uso per fare pressione sulle voci scomode.
Pechino continua a perseguitare illegalmente le famiglie di attivisti e dissidenti. A lanciare l’allarme è Chinese Human Rights Defenders (CHRD) nel suo ultimo report “If I Disobey, My Family Will Suffer: Collective punishment of human rights defenders’ families in China”. Pubblicata lo scorso 15 aprile, l’indagine sottolinea come intimidazioni e molestie, sgomberi forzati, divieti di espatrio, e procedimenti penali continuano a essere strumentalizzati contro i parenti dei condannati per reati economici e politici. Una pratica nota in Cina come “punizione collettiva” che a dicembre scorso l’Assemblea nazionale del popolo, il parlamento cinese, ha promesso di abolire.
Il rapporto identifica nel solo 2023 decine di nuovi casi del genere; alcuni hanno coinvolto le minoranze etniche uigura e tibetana, nonché residenti di Hong Kong, dove la crescente ingerenza di Pechino nell’ultimo quinquennio ha inibito la società civile.
Ricordando come “la legge cinese non fornisce alcuna base legale per questa pratica perversa, che è vietata dal diritto internazionale”, il gruppo con sede a Washington chiede che la Cina “cessi immediatamente tutte le molestie e le detenzioni extralegali nei confronti dei familiari dei difensori dei diritti umani”. Il CHRD ha anche invitato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, a rilasciare dichiarazioni energiche in merito alle violazioni dei diritti commesse dal governo cinese nonché a fornire aggiornamenti regolari sullo stato dei colloqui con i funzionari di Pechino.
Quella della “punizione collettiva” non è un’usanza introdotta in tempi recenti, bensì un retaggio del periodo pre-imperiale. Associata al regno di Qin, durante il periodo degli Stati Combattenti (475-221 a.C.), l’usanza è stata successivamente ereditata dalla dinastia Qin (221-206 a.C.) sotto l’influenza della scuola ideologica dei legalisti, che dettò la linea autoritaria del primo imperatore Qin Shi Huang. All’epoca la “punizione collettiva” si applicava a tutti: funzionari governativi, militari e gente comune ne subivano le gravi conseguenze, fatta eccezione solo per il re e, più tardi, l’imperatore.
Negli ultimi anni, la pratica ha trovato ampio spazio nell’ambito del crescente controllo esercitato dall’amministrazione Xi Jinping sul dissenso. Il prezzo più alto lo ha pagato Dong Jianbiao, padre di Dong Yaoqiong, la ragazza che nel 2018 è stata sottoposta a detenzione psichiatrica per aver girato un video mentre imbrattava con la vernice un poster del presidente cinese. Dopo aver cercato di rendere note le condizioni della figlia, nel 2022 l’uomo è morto in prigione in circostanze sospette; il suo corpo, rinvenuto coperto di sangue con diversi segni di contusioni, è stato rapidamente fatto cremare dalla polizia nonostante la famiglia avesse richiesto un’autopsia.
Ma a preoccupare l’ong è soprattutto l’impiego della pratica ai danni di minori. Secondo CHRD, “neonati e bambini piccoli sono stati detenuti in reparti psichiatrici o orfanotrofi”, “costretti ad abbandonare la scuola” o impossibilitati ad “andare all’estero per motivi di studio”. Caso esemplare è quello di Wang Quanzhang, noto avvocato per i diritti umani condannato a quattro anni e mezzo di prigione con l’accusa di sovversione nel quadro della cosiddetta “repressione 709” avviata da Pechino nel luglio 2015. Dopo il rilascio, non solo Wang è stato sottoposto a sfratto una decina di volte. Nell’ultimo anno anche il figlio 11enne è stato ripetutamente allontanato da diverse scuole.
Sorte simile è toccata ai figli di altri attivisti perseguitati dalle autorità cinesi. Secondo il rapporto, il bambino del dissidente He Fangmei è stato affidato a una famiglia adottiva dopo la detenzione del padre nel febbraio 2021, mentre le sue due sorelle, all’epoca di quattro e un mese d’età, sono state internate in un ospedale psichiatrico nonostante le ripetute suppliche dei parenti. Altrettanto triste la storia di Yu Zhenyang, il figlio del noto avvocato per la difesa dei diritti umani Yu Wensheng, arrestato per l’ennesima volta con la moglie Xu Yan nell’aprile 2023. Il ragazzo, tuttora sotto stretta sorveglianza della polizia, ha tentato il suicidio due volte lo scorso novembre.
Sebbene la pratica della “punizione collettiva” sia utilizzata perlopiù contro cittadini cinesi, sono diversi gli stranieri ad aver riscontrato pressioni simili sui propri familiari. Soprattutto attraverso il cosiddetto “exit ban”, una forma di divieto di rimpatrio autorizzato dalle leggi cinesi, su cui si è espressa con preoccupazione anche l’amministrazione Biden. Lo scorso anno il Dipartimento di Stato americano ha avvertito che i cittadini statunitensi di origine cinese rischiano di “essere soggetti a ulteriori controlli e molestie” mentre si trovano nel paese asiatico; soprattutto se sono parenti di dissidenti o altre figure scomode residenti all’estero che Pechino vuole indurre a tornare in Cina.
Se la storia serve di insegnamento, vale la pena ricordare come l’applicazione della “punizione collettiva” fu una delle molteplici cause del diffuso malcontento popolare che provocò la caduta della dinastia Qin. Come in altre occasioni, Pechino ha dimostrato di prendere molto seriamente i moniti del passato. Alla fine dello scorso anno, dopo aver ricevuto 2.827 richieste di revisione, l’ANP ha individuato regolamenti amministrativi e interpretazioni giudiziarie che “contraddicono i principi e lo spirito della Costituzione”; motivo per cui ha espressamente chiesto l’abolizione della “punizione collettiva”. Ma quando in gioco c’è la longevità del Partito unico, passare dalle parole ai fatti non è mai semplice.
Di Alessandra Colarizi
[Pubblicato su Gariwo MAG]
Classe ’84, romana doc. Direttrice editoriale di China Files. Nel 2010 si laurea con lode in lingua e cultura cinese presso la facoltà di Studi Orientali (La Sapienza). Appena terminati gli studi tra Roma e Pechino, comincia a muovere i primi passi nel giornalismo presso le redazioni di Agi e Xinhua. Oggi scrive di Cina e Asia per diverse testate, tra le quali Il Fatto Quotidiano, Milano Finanza e il Messaggero. Ha realizzato diversi reportage dall’Asia Centrale, dove ha effettuato ricerche sul progetto Belt and Road Initiative. È autrice di Africa rossa: il modello cinese e il continente del futuro.